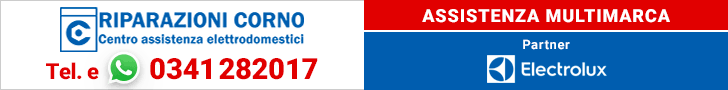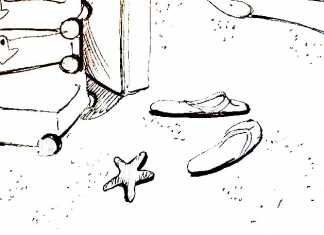Antigone e il contrabbasso – Occorre, dunque, distinguere, separare. Isolare l’enigma del limite dalla sua degenerazione moralistica, pena altrimenti, come si suole dire, gettare via il bambino assieme all’acqua sporca. Va da sé, inoltre, che anche un fugace accenno a una simile questione si trascina immediatamente appresso una tematica non poco ingombrante e fonte inesauribile di imbarazzo, quella della colpa. Argomento scandaloso che sarebbe tuttavia inopportuno trascurare o, ma al fondo è lo stesso, considerare come espressione di uno stato d’animo al quale dovrebbe esser negata ogni legittimità psichica. Come se il problema fosse la colpa e non quel che la genera.
Antigone e il contrabbasso – Occorre, dunque, distinguere, separare. Isolare l’enigma del limite dalla sua degenerazione moralistica, pena altrimenti, come si suole dire, gettare via il bambino assieme all’acqua sporca. Va da sé, inoltre, che anche un fugace accenno a una simile questione si trascina immediatamente appresso una tematica non poco ingombrante e fonte inesauribile di imbarazzo, quella della colpa. Argomento scandaloso che sarebbe tuttavia inopportuno trascurare o, ma al fondo è lo stesso, considerare come espressione di uno stato d’animo al quale dovrebbe esser negata ogni legittimità psichica. Come se il problema fosse la colpa e non quel che la genera.
Lo psicologismo ha prodotto non poca confusione, in proposito. Spesso ha lasciato intendere come il sentimento di colpa costituisse un problema in sé, in quanto causa di un disagio nel soggetto. La cultura della colpevolizzazione, tipica degli anni passati, è stata così progressivamente sostituita da quella della de-colpevolizzazione, una sorta di ideologia dogmatica insieme, in grado di coniugare i furori deliranti nicciani con le astruse vaghezze libertine rivedute e rilanciate in chiave “new age” . In questo caso, il passaggio dal modello asfissiante della colpevolizzazione a quello apparentemente opposto della de-colpevolizzazione è servito a evitare una ponderata riflessione sul significato e sul valore della colpa come dato strutturante il funzionamento psichico del soggetto, nel suo rapporto con sé stesso non meno che con gli altri. La cifra patologica dell’eccesso che, ora in un senso, ora in un altro, si determina abitualmente attorno ad essa, ha infatti ostacolato tale processo, privilegiando la ricerca di una sorta di ipotetico punto d’equilibrio tra i due suddetti estremi, questione puramente immaginaria. E’ rimasto così in ombra il nodo della colpa o del Super-Io freudiano come accadimento psichico, misterioso e necessario, che, insisto, è né più né meno la problematica stessa dell’essere del soggetto in quanto tale, clinica ed etica nel contempo. La colpa, infatti, designa l’insieme di quel che accade nello psichismo del singolo come ritorno del suo manifestarsi soggettivo, nelle azioni o anche solo nell’intenzionalità. Supporre di vanificarla comporta implicitamente il pensiero di dissolvere il soggetto stesso, scorporando il suo essere o la sua mancanza a essere dalle conseguenze del suo proprio esistere, del suo porsi in atto. La colpa, al contrario , unisce l’uno all’altro nell’esatta misura in cui tiene in gioco, dietro ad essa, la memoria inconscia della relazione asimmetrica che il soggetto ha intrattenuto, in precedenza, con le persone che lo hanno accudito.
Una traccia dell’altro, un atteggiamento della madre o del padre o di quelli che Freud chiama come i (“genitori) della propria preistoria personale” , è “entrata” nel soggetto, costituendolo e , col medesimo atto , dividendolo. Un’operazione che si rinnova costantemente nell’incontro con gli altri, nelle differenti occasioni che la vita crea. Anche, e non a caso, nell’approccio con il disabile.
Si può considerare, sotto questo profilo, lo stretto rapporto che tradizionalmente salda l’insorgere o il perdurare della colpa con il rendersi presente dello sguardo di un altro, prima ancora della sua parola. Per quanto, nello specifico, poi attiene l’handicap, un simile legame si è spesso mostrato nelle sue forme più estreme, nefaste e paradossali. Le pratiche di segregazione o di eliminazione dei disabili hanno reperito e tutt’ora reperiscono un loro tratto fondante nell’azione violenta di soppressione di quel che segnala il palesarsi del soggetto : il suo sguardo. Sopprimere il suo esserci è , in primo luogo, cancellare il suo sguardo, far sì che non compaia, evitando in questo modo che nasca un interrogazione colpevolizzante per l’individuo sedicente normale. I muri di molte strutture per handicappati hanno sempre svolto questa funzione: rendere non visibile il disabile agli occhi del normale, in modo che il suo sguardo non incrociasse quello di quest’ultimo, rammentandogli la propria sventurata esistenza, richiamandolo a un principio di responsabilità nei suoi confronti.
Non senza ovviamente passare per il tramite dell’unico elemento in grado di stendere un filo di collegamento tra lo sguardo del disabile e l’atteggiamento respingente del “normale”: il fantasma della colpa. Comunque la si interpreti, tenendosi a debita distanza dalla esasperazioni sado-masochistiche che possono accompagnarla, non è forse per la sua via che l’ombra dell’altro, il sentimento del suo stare nel mondo come essere umano si affaccia alla coscienza di chi gli sta accanto? Non più solo un corpo, un’etichetta, una categoria… Ma un umano tra gli umani, come tale riconosciuto nella e dalla comunità civile. Il dato clinico caratteristico della psicosi e della perversione, cioè di quelle patologie gravi che hanno necessariamente alla base l’invalidazione del riferimento simbolico all’Edipo, è quello inerente il processo di oggettivazione dell’altro, la sua riduzione nel senso letterale del termine a puro oggetto di godimento, a feticcio da utilizzare a proprio esclusivo piacimento, arida metonimia di quel che era il rapporto incestuoso con la madre.
La colpa, in quanto erede funzionale del Super-Io freudiano, isola un crocevia non aggirabile dove si dispone la questione del soggetto, come si è detto, indissociata da quella del suo rapporto con gli altri. Piaccia, o meno. La delicata questione della responsabilità ne dipende, di conseguenza. E’ per questo che, al fondo, le eventuali linee di fuga dal tema della colpa producono in genere un effetto boomerang che si ritorce sull’individuo medesimo.
L’ innegabile esistenza di altre istanze psichiche o di differenti moti affettivi non possono eludere la strettoia che la problematica inerente alla colpa istituisce come un passaggio obbligato, indispensabile nell’essere di un soggetto. Piuttosto, vi si aggiungono, vi s’intrecciano, vi convivono, interagendo con essa, in maniera spesso conflittuale. E’ , in definitiva, quel che accade con quella beanza che ha nome desiderio e che con la colpa, come è immaginabile, instaura una relazione contorta, ben poco lineare. Parlando di disabilità, ci sembra un argomento non sottovalutabile.
La responsabilità non coincide sempre o obbligatoriamente con il desiderio , può anche darsi che, in parecchi casi, le faccia da indispensabile e prosaico contrappeso. Il desiderio privilegia un orizzonte che mobilita la mancanza a essere del soggetto, la sua intenzionalità e l’oggetto attorno al quale si organizza. La responsabilità può, al contrario, apparire come associata al manifestarsi di un appello al soggetto, un richiamo o un invito anche controvoglia o in opposta tendenza a quei desideri che lo porterebbero invece da tutt’altra parte. Il desiderio comporta anch’esso una responsabilità, Lacan ne sottolinea il significato per l’esistenza del singolo, assegnandogli un valore etico. La grande colpa di cui il soggetto potrebbe macchiarsi sarebbe infatti, agli occhi dello psicoanalista francese, proprio quella di aver ceduto su questo punto, di aver lasciato che il suo desiderio man mano si stemperasse nel campo della vaghezza immaginaria sino a reperire un facile conforto nel rimorso per l’occasione perduta. Ciò non suppone tuttavia, insisto, che una responsabilità comporti un desiderio. Può darsi che, a questo proposito, non suoni affatto fuori luogo un passo del commento del Pirqé Avot (Il trattato dei padri) che così recita: “non ti è imposto di compiere l’opera nella sua totalità , ma non sei libero di sottrarti totalmente” 1 .
Può , in tal senso, il desiderio prestarsi a indicare una possibile sottrazione da una responsabilità che non sia quella prescritta dal desiderio stesso? Nel suo seminario sull’etica, Lacan propone il personaggio di Antigone , protagonista dell’eponima tragedia sofoclea, come esemplificatrice di una testimonianza radicale nel senso proprio della mancanza a essere. Riassumiamone rapidamente la vicenda: il nuovo re di Tebe, Creonte, ordina che il corpo di Polinice, fratello di Antigone, rimanga insepolto. Polinice che aveva guidato un attacco poi fallito contro la città è considerato un traditore della patria. Mentre la sua timorosa sorella, Ismene, si fa da parte, Antigone dichiara orgogliosa che si atterrà alle leggi divine della pietà e cerca per due volte di dare una sepoltura al fratello. Sorpresa dalle guardie, Antigone è condannata a morte. Dopo le ammonizioni dell’indovino Tiresia, Creonte ha un ripensamento. Troppo tardi, ormai. Antigone si è impiccata. Creonte si sente solo e disperato, maledice sé stesso e invoca la morte.
Dramma complesso e ricco di più risvolti problematici di quanti potrebbero appare a prima vista. Hegel stesso , a suo tempo, metteva in guardia lo spettatore davanti a una lettura eccessivamente manichea dell’intera storia. Come se Creonte incarnasse il male e Antigone, il bene. La figura dell’eroina sofoclea non ha tuttavia cessato di affascinare , nei secoli, autori differenti che ne hanno fornito rappresentazioni spesso contraddittorie tra loro, si pensi a Brecht e a Anouilh, capaci di mettere in luce i tratti paradossali del personaggio.
Desiderio e morte si saldano tra loro nella triste vicenda della figlia di Edipo, l’interpretazione lacaniana lo sottolinea con forza, influenzata com’ è dalla speculazione metafisica heideggeriana. Il desiderio portato alle sue conseguenze estreme sfocia o , comunque, risolve la vita nella morte che così assicura all’esistenza un senso. Determinata, inflessibile, Antigone avanza in quella che Eliot designerebbe come una “wasted land”, una terra di nessuno, come dice Lacan: lei “porta fino al limite il compimento di ciò che si può chiamare il desiderio puro , il puro e semplice desiderio di morte come tale. Questo desiderio lei lo incarna.” 2 Non a caso uno psicoanalista e allievo del maestro francese come Giacomo Contri accosta la psicologia di questo tragico personaggio a quello dell’integralismo fondamentalista. Recalcati, da parte sua, marca giustamente le differenze : “Il terrorista nella sua furia fondamentalista, usa la morte per seminare terrore e realizzare l’utopia funesta della realizzazione della Causa, mentre Antigone accetta innanzitutto la propria morte…. Antigone non ammazza, non elimina l’impuro, ma assume su di sé il peso della sua scelta singolare” 3.
Sia come sia, la morte appare come un destino inevitabile che proietta la sua inquietante ombra sullo sviluppo dell’intera vicenda di Antigone. Figlia d’un incesto, lei si candida spontaneamente a seguire la sorte del fratello, un cadavere che se aggiunge a un altro, ostentando indifferenza, quando non disprezzo, per l’amore e per il domani. Nella disabilità, la morte o , per lo meno, il suo fantasma si presenta sin da subito, come un doppio dell’esistenza stessa. Un trauma duro da rimuovere, un tormento interiore reticente ad andarsene, o , anche solo, ad allentare la presa. Il caso di Michele lo mostra in maniera paradigmatica. Morte annunciata, morte incastrata nella vita stessa, oppure, in altre situazioni, morte psichica: abisso al quale è sottratto un fondo, a meno di non denominarlo rassegnazione, dove vanno a infrangersi le illusioni narcisistiche dei “normali” in attesa di poter risorgere altrimenti, una volta passate al setaccio della castrazione. Diverse associazioni di genitori di figli disabili recano esplicitamente nel loro nome o in quello dei progetti che organizzano un richiamo “al dopo di noi” che assegna una connotazione escatologica alle loro iniziative. Si tratta di una formula efficace che, per l’appunto, è chiamata a prendere di petto il tema della morte, bussola che orienta la questione della responsabilità. S’intuisce lo scenario che prefigura. La scomparsa del familiare ha come prevedibile effetto quello di condannare il figlio, magari divenuto adulto, all’indigenza o alla trascuratezza da parte degli altri. Come se, insomma, il venir meno dei familiari anticipasse, di conseguenza, il palesarsi di un peggioramento delle condizioni di vita per l’individuo portatore d’handicap, quasi fosse un’anticamera a una sua prossima e prevedibile dipartita, dalla vita o, anche, nella vita.
I familiari, ma non solo loro, viaggiano lungo un crinale sottile, quello che separa la vita dal suo svuotarsi, dal suo ritornare all’inanimato o al caos. Si dirà tuttavia che anche la loro azione, e dunque la loro etica, risponde a un desiderio. E, quindi, non a un meccanico e asfissiante imperativo sociale, moralmente ambiguo. Se dipendesse solo da quello, l’insieme mal funzionerebbe e per primo l’atto stesso ne risentirebbe, gravandosi di un peso che lo renderebbe inautentico, costrittivo.
Freudianamente, il desiderio si configura come caratterizzato dal ritrovamento di un oggetto, in precedenza perduto, mediato per il tramite delle costruzioni fantasmatiche inconsce. Alla lettera, per l’appunto, il ritrovamento è un trovare, di nuovo. Ciò assegna al desiderio una doppia figura, quella cioè di apertura, di slancio in avanti, ma altresì di recupero, seppur in una forma parziale e diversificata, di quel è andato inevitabilmente perso. E’ il motivo, al fondo, che permette di poter coglierne la sua declinazione lungo una linea di sviluppo anche potenzialmente evolutiva, nel passaggio da una fase a un’altra, da un oggetto a un altro e così via.
Accade ,tuttavia, che la vita riservi spesso l’incontro con perdite tanto improvvise quanto inassimilabili, traumi adialettici o mutamenti sconvolgenti, come ricorda lo stesso Freud in parecchi testi. O, forse, anche più semplicemente, incombenze che l’esistenza pone dinnanzi agli individui e che domandano a quest’ultimi di rinunciare a quel narcisismo che, comunque, il desiderio veicola.
Contrapporre il desiderio al sacrificio presuppone uno schematismo fuorviante e di cui, per altro, Antigone non incarna la figura più nitida a riguardo. In un breve racconto dal titolo “ Perché uccidere il contrabbasso?” 4, lo scrittore scandinavo Stig Dagerman racconta la storia di un uomo che nutriva una grande passione per il contrabbasso. La nascita di un figlio, desiderato da tanto tempo, “anche se non ne avevano mai parlato “ 5 , finisce per porre il musicista davanti a una drastica scelta, un aut aut che non concede tregua. O il contrabbasso o il bambino. In estrema sintesi: o il desiderio o …
Saggiamente, Dagerman fa notare la necessità per il genitore di far sua “ l’arte di trovare un equilibrio” che gli consenta di non rinunciare né al contrabbasso né al bambino (o , più precisamente, al suo essere padre) , ipotizzando che , in futuro, ad esempio, l’adulto possa far conoscere al figlio il suo desiderio, introducendolo così al suo mondo. Soluzione indubbiamente condivisibile, capace di smorzare il rigido antagonismo tra desiderio e sacrificio, tra la dedizione a un proprio interesse e il sacrificio masochistico al servizio della domanda degli altri, ma non del tutto convincente. La complementarietà, così come l’idea di un’equa mediazione, nutrono entrambi l’utopia seducente di una pacificazione, quello, cioè, dell’addomesticamento della perdita o della sua regolata gestione.
La realtà è più semplice o, probabilmente, più dura e intransigente. Complice del caso, essa dispone del potere immenso di far saltare equilibri, spesso conquistati a fatica. Ciò finisce per collocare spesso il singolo individuo davanti a scelte che occorrerebbe scrivere virgolettate nella misura in cui si costituiscono in stretta conseguenza ad eventi che il soggetto subisce, in un modo o nell’altro. Episodi, situazioni che possono mutare radicalmente il corso della sua vita e che, per ritornare al Super-Io freudiano, costringono una persona a fare i conti con il non voluto, e quindi con una dimensione economica psichica anti-narcisistica, anti-incestuosa. Scelte del genere assumono il valore di una risposta con la quale il singolo prende , di fatto, una posizione, inevitabilmente soggettiva, nei riguardi dell’accadimento oggettivo che lo coinvolge, ben oltre il suo desiderio. Da quel momento in poi, la sua vita è sollecitata a imboccare un’altra direzione, potenzialmente capace di assorbirla per intero. La “scelta” rappresenta così la risposta, insisto su questo termine, a una chiamata: dinamica che mi sembra presieda adeguatamente a un principio di responsabilità che non può non includere l’altro allo stesso titolo che sé stessi. Vivere è convivere, comunque. L’inferno sono gli altri, sentenziava un personaggio teatrale sartriano. Frase celebre, troppo roboante per non essere falsa, troppo esagerata per non essere vera. Un antidoto salutare al sentimentalismo mieloso e ipocrita. Evidentemente, però, non basta…
Fuor di ogni retorica, la responsabilità o quel che si presenta sotto quel nome declina la matrice di un sintomo che , per un verso, tende a stringere e , per un altro, tende ad allentare il rapporto con l’altro, traducendo e tradendo il manifestarsi, per l’appunto, di una risposta a fronte dell’emergere di una presenza, al dispiegarsi di un incontro . In quanto sintomo, per eccellenza umano, accettato e assunto, messo in parole e in atti, la responsabilità è altro dal rigetto, dall’ideale, dal sacrificio e, come si è detto, dal desiderio “tout court” cui non invidia, di certo, la dignità. Forse, per tornare al caso di Lara da cui siamo partiti, è incominciare a stare lì, impresa per la verità non sempre delle più agevoli, al suo fianco. Con lei, evitando di mettersi al suo posto. Accettando così il prezzo amaro che la sua disabilità richiede, quello cioè di sperimentare una comunicazione frammentata, incompiuta, il più delle volte in grado di mettere a dura prova un processo minimale di comprensione. Tocca al cosiddetto normale, e a chi se no?, prodigarsi per far esistere quel dono del dire che l’handicap ha mutilato. E’ un modo per guardare in faccia il tragico assicurandogli una rappresentazione, non obbligatoriamente depressiva, che tessa la trama di un legame, sbilanciato e paradossale quanto vogliamo, attraverso il quale una socialità può prendere forma. L’unica che sappiamo produrre, l’unica nella quale le nostre vite possono trovare un respiro, un’ansia civile che non le soffochi.
1) AA.VV. – Commentaires du Traité des Péres (Pirqé Avot) – Verdier, Paris, 1990, p. 121
2) Jacques Lacan- Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi. 1959-1960 – Einaudi, Torino, 1994, p .356
3) Massimo Recalcati – Ritratti del desiderio – Raffello Cortina, Milano, 2012, p. 150
4) In Stig Dagerman – Perché i bambini devono ubbidire? – Iperborea, Milano, 2013, p. 43-49
5) “… In realtà non avevano mai parlato di niente, lui suonava e lei ascoltava…” , idem, p. 43
ARTICOLI PRECEDENTI
24 luglio – Sulla così detta responsabilità, infine (Seconda parte)
18 luglio – Sulla così detta responsabilità, infine
10 luglio – L’eroina torna a fare paura
11 giugno – Non si può cambiare la testa e il cuore di un bandito. Intervista a Corrado
4 giugno – La fiaba e il bambino
28 maggio – Chi domanda una cura?
21 maggio – Bocciatura, come comportarsi?
14 maggio – Il gioco d’azzardo in provincia di Lecco
23 aprile – Cambiare scuola… che ansia
13 aprile – Il gioco è una cosa seria (seconda parte)
2 aprile – L’auto stima ovvero l’autre-stima
10 marzo – Dal 2014 meno cibo per i poveri
4 marzo – Dentro, fuori le mura. Una considerazione su carcere e rieducazione
26 febbraio – Ripartire per la vita…. Il progetto “RESTART” e la clinica delle dipendenze
18 febbraio – Il mondo è un intreccio. Riflessioni sull’integrazione culturale
12 febbario – Il gioco è una cosa seria (prima puntata)
4 febbraio – Da donna a madre: una crisi di identità
30 gennaio – Figli di una ragione minore (2^ parte)
21 gennaio – Figli di una ragione minore
14 gennaio – I nuovi media: diavolo o acqua santa?
7 gennaio 2013 – Insieme si può
24 dicembre – Un Gioco a perdere. Due considerazioni sul gioco d’azzardo
17 dicembre – I più e i meno dell’educare
10 dicembre – Il vento ci porterà…
3 dicembre – Essere genitori dentro ad un conflitto nella coppia
26 Nvembre – Una professione in cammino
19 novembre – La famiglia errante
12 novembre – … è solo un farmaco…
5 novembre – A cavallo della vita. Per un desiderio del disabile
29 ottobre – L’iperattività si eredita?
22 ottobre – La droga non è un vizio. Una riflessione sul lavoro sulla tossicomania
15 ottobre – Nasce CALeidoscopio, la nuova rubrica dedicata al sociale

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL