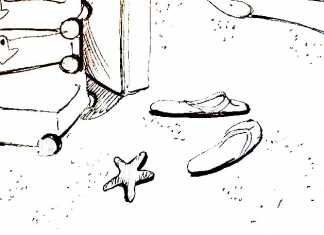Incontro davvero intenso quello organizzato da Appello per Lecco in Sala Ticozzi con Giuseppe Ayala, magistrato e politico italiano attivo in Sicilia fin dai primi anni ottanta nella lotta contro la mafia, e poi strettissimo collaboratore nelle indagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino ad essere pubblico ministero del primo Maxiprocesso di Palermo che portò nel 1987 alla condanna di oltre 400 persone per reati legati alla criminalità organizzata.
Incontro davvero intenso quello organizzato da Appello per Lecco in Sala Ticozzi con Giuseppe Ayala, magistrato e politico italiano attivo in Sicilia fin dai primi anni ottanta nella lotta contro la mafia, e poi strettissimo collaboratore nelle indagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino ad essere pubblico ministero del primo Maxiprocesso di Palermo che portò nel 1987 alla condanna di oltre 400 persone per reati legati alla criminalità organizzata.
Attraverso il racconto di aneddoti ripercorsi anche con la lettura di alcuni passi del suo libro “Chi ha paura muore ogni giorno” (titolo che riprende una celebre frase del magistrato Paolo Borsellino), Ayala ha ricordato la straordinaria vicenda giuridica e umana della difficile lotta a Cosa nostra, con i suoi fondamentali successi ed i tragici eventi che l’hanno accompagnata.
Il magistrato ha voluto subito chiarire un punto fondamentale: “L’idea comune è che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone siano stati due uomini eccezionali, due eroi della patria; cosa assolutamente vera, ma che rischia di creare il pericoloso preconcetto che la lotta alla mafia possa essere combattuta solo da persone fuori dal comune, da uomini straordinari. Per quanto mi riguarda, considero ancora oggi Paolo e Giovanni, oltre che due amici mossi da grande semplicità umana, due servitori dello Stato, due magistrati animati da uno straordinario senso delle Istituzioni; questo deve essere il loro esempio più grande”.
Una lotta professionale, ma anche uno straordinario rapporto d’amicizia che ha scavato una voragine  incolmabile con la tragica scomparsa di Falcone: “ Ho vissuto la morte di Giovanni come una mutilazione; lui ha avuto il potere di cambiarmi la vita due volte, al nostro primo incontro e quando se ne è andato per sempre. Dal 1992 ho dovuto imparare a convivere con una nevrosi irrimediabile, una lacerazione insanabile. Ed è anche per questo che continuo giorno dopo giorno a seguire un suo insegnamento: Giovanni mi ha sempre detto che chi resta deve stare ben attento a non cadere nella sindrome del reduce. Chi resta ha il dovere di contribuire con la propria testimonianza, che serva a ricordare ma soprattutto a far capire lo stato reale delle cose, divulgando la storia per quello che realmente è stata”.
incolmabile con la tragica scomparsa di Falcone: “ Ho vissuto la morte di Giovanni come una mutilazione; lui ha avuto il potere di cambiarmi la vita due volte, al nostro primo incontro e quando se ne è andato per sempre. Dal 1992 ho dovuto imparare a convivere con una nevrosi irrimediabile, una lacerazione insanabile. Ed è anche per questo che continuo giorno dopo giorno a seguire un suo insegnamento: Giovanni mi ha sempre detto che chi resta deve stare ben attento a non cadere nella sindrome del reduce. Chi resta ha il dovere di contribuire con la propria testimonianza, che serva a ricordare ma soprattutto a far capire lo stato reale delle cose, divulgando la storia per quello che realmente è stata”.
Una riflessione quindi sull’evoluzione del fenomeno mafioso come struttura di potere che, storicamente radicato in Sicilia e più in generale nel Sud Italia, è venuto ad assumere dimensioni difficili da immaginare; uno sviluppo che trova straordinaria esemplificazione nelle parole di Leonardo Sciascia, che ne “Il giorno della civetta”, già nel 1961, utilizzava l’immagine della “linea della palma” paragonando la diffusione della vegetazione della Sicilia verso il Nord Italia alla futura penetrazione dell’attività e del controllo mafioso verso la ricca economia del Nord.
 Realtà che hanno toccato e toccano da vicino la realtà lecchese, ritornate pesantemente alla ribalta anche dopo la pubblicazione di “Metastasi” libro che raccoglie le confessioni del pentito Di Bella, viatico di un acceso dibattito che ha creato un vero e proprio caos nell’opinione pubblica.
Realtà che hanno toccato e toccano da vicino la realtà lecchese, ritornate pesantemente alla ribalta anche dopo la pubblicazione di “Metastasi” libro che raccoglie le confessioni del pentito Di Bella, viatico di un acceso dibattito che ha creato un vero e proprio caos nell’opinione pubblica.
Per questo l’ultimo messaggio di Ayala è volutamente semplice, ma assolutamente efficace: “In Italia spesso, troppo spesso, viene meno la cultura del diritto, della legalità, della meritocrazia; la legalità è certamente una scelta etica, ma sarebbe altrettanto necessario entrare nell’ottica di viverla come una convenienza. Il rispetto delle regole è la base di una sana democrazia, e la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno mafioso sono altresì i presupposti fondamentali per lo sviluppo di un circolo virtuoso che deve essere il motore della reale, libera, sovranità del popolo”.
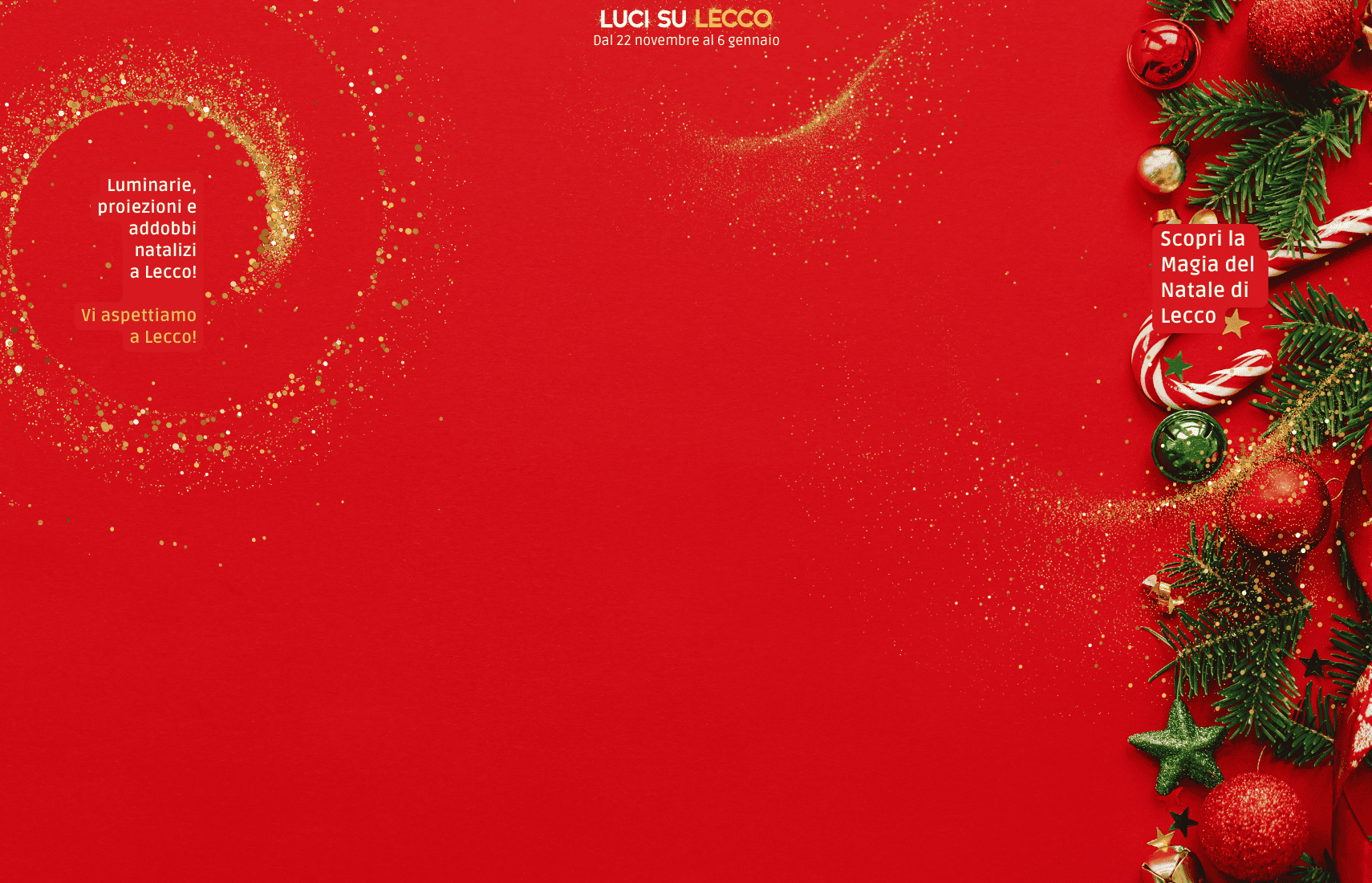
 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL