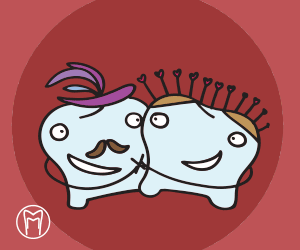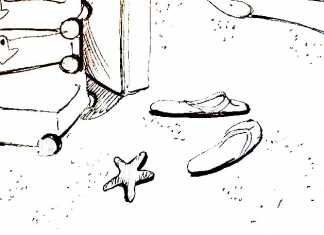“Il mio amico Giovanni”. Pietro Grasso racconta, prima che l’eroe, l’uomo Giovanni Falcone
Ospite del festival Leggermente, l’ex magistrato e senatore presenta il suo libro a Mandello e incontra gli studenti a Oggiono
MANDELLO / OGGIONO – “Mi emoziono a tenere in mano questo libro. Dopo trent’anni c’è il rischio che i ricordi si attenuino, e che persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino siano dimenticate. In questo spera la mafia, ma farò di tutto per mantenerne viva la memoria, soprattutto nei ragazzi, servendomi di oggetti tangibili come questo volume”.
Così esordisce Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex Presidente del Senato, nella serata dedicata alla promozione del suo nuovo libro “Il mio amico Giovanni”, presentato in prima assoluta nazionale al Teatro San Lorenzo di Mandello del Lario domenica sera e di nuovo questa mattina, lunedì, al Palabachelet di Oggiono davanti agli studenti delle scuole lecchesi.
Un incontro, organizzato nell’ambito della rassegna lecchese Leggermente dedicata alla lettura, che dall’inizio alla fine sarà caratterizzato dalla commozione, anche se durante il dialogo tra l’onorevole Grasso e Paolo Valsecchi, giornalista e conduttore del dibattito, non mancherà lo spazio per momenti di leggerezza accompagnati da qualche battuta.

L’emozione si fa palpabile già nelle parole di Doriana Pachera, assessore alla Cultura chiamata a introdurre l’evento e presentarne i protagonisti: “Per noi è una serata estremamente importante, avere qui il Presidente Grasso è un onore. Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale ci tengo a ringraziare Confcommercio Lecco e Leggermente per l’opportunità data, oltre che l’Associazione Oratori Mandello per averci messo a disposizione gli spazi del teatro“.
Le uccisione di Giuseppe Letizia e di Placido Rizzotto spiegano la mafia
L’incipit de “Il mio amico Giovanni” parte dal racconto di Giuseppe Letizia, un giovane ragazzo e pastore ucciso nel 1948 a Corleone, in provincia di Palermo, colpevole di aver assistito una notte, mentre badava al suo gregge, all’assassinio del sindacalista Placido Rizzotto per mano del mafioso Luciano Liggio e altri due compari, tutti appartenenti alla cosca di Michele Navarra. Trovato in stato delirante il giorno successivo dal padre, quest’ultimo decise di portare Giuseppe in ospedale a Corleone, dove confessò di aver assistito a questa colluttazione. Dopo un giorno trascorso in clinica, il ragazzo inspiegabilmente morì.

Come causa della morte venne dichiarata una tossicosi alimentare, ma in realtà al giovane fu somministrato del veleno. A ordinarne l’iniezione proprio Michele Navarra, al tempo direttore della clinica, per non consentirgli di raccontare quanto aveva visto. Grazie alle indagini dell’allora comandante Carlo Alberto dalla Chiesa, si riuscirono a individuare i colpevoli, ma purtroppo la giustizia non riuscì ad avere seguito, sia per via delle ritrattazioni messe in atto dai malavitosi, che per il mutismo perpetrato dai familiari, chiamati a testimoniare in aula di tribunale.
“Ho scelto di aprire il libro con questo episodio perché Giovanni e io ne parlavamo sempre, lo analizzavamo – racconta l’onorevole Pietro Grasso -. Attraverso le nostre riflessioni, siamo giunti alla conclusione che il caso Giuseppe Letizia e Placido Rizzotto contenga tutti gli elementi necessari a spiegare l’essenza della mafia: c’è l’omertà dei malavitosi, il silenzio dei familiari, la vittima oculare colpevole solo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alcuni dicono che Letizia sia stato sfortunato, ma la vera sfortuna è che ci fosse la mafia”.

Bisognerà attendere il 2012 per dare degna sepoltura con dei funerali di Stato a Rizzotto, a seguito del ritrovamento e accertamento tramite prova del DNA dei suoi resti.
Il racconto del Maxiprocesso a Cosa Nostra
A distanza di quasi trent’anni dalla strage di Capaci, in tanti ricordano più l’episodio che ha sancito la fine di Giovanni Falcone, piuttosto che i risultati da lui ottenuti in vita. “Solo dopo il Maxiprocesso a Cosa Nostra, cominciato nel 1986, si è iniziato a dare un nome alla mafia. Da lì nessuno ha più potuto negarne l’esistenza”, spiega Grasso.
Gli innumerevoli omicidi che coinvolsero verso la fine degli anni ’70 persone investite delle più disparate cariche istituzionali, spinsero alla creazione di un Pool antimafia formato dai migliori magistrati, tra cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
“Per la prima volta non si decise di soffermarsi sui singoli avvenimenti, ma di coordinare le indagini tra loro per raccogliere tutti i tasselli e avere una chiara visione d’insieme, individuando in questo modo la totalità dei soggetti coinvolti – prosegue Pietro Grasso -. Falcone fu peraltro il primo magistrato a concentrarsi non tanto sui corpi delle vittime, quanto sulle transazioni di denaro. Un corpo si può far scomparire, diceva sempre, ma l’odore dei soldi resta“.
Così si costruirono le basi per il Maxiprocesso, anche se decisive furono le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, indispensabili per comprendere i meccanismi sottostanti a Cosa Nostra, i riti d’iniziazione, la struttura delle famiglie, le decisioni rispetto agli omicidi da compiere.
“È curioso notare come nel linguaggio mafioso siano ricorrenti termini a cui generalmente assegniamo un alto valore morale, come famiglia, onore, rispetto, amicizia, padrino, che nel contesto malavitoso assumono invece un’accezione maligna”, continua Grasso.
Come spesso accade quando la vita prende una svolta decisiva, Pietro Grasso rammenta ancora il giorno in cui è stato chiamato a fare da giudice nel Maxiprocesso: “Ricordo che ero in vacanza. Stavo scrivendo una sentenza quando mi chiamò il Presidente del Tribunale di Palermo, dicendo che doveva parlarmi e che avrebbe mandato una macchina con l’autista a prendermi. Intuii subito che si trattasse di qualcosa di grosso. Prima di accettare l’incarico ne parlai con mia moglie: sapevo che da lì in poi la mia esistenza sarebbe cambiata, che la libertà mi sarebbe stata limitata, che saremmo stati oggetto di minacce e intimidazioni”.
Nonostante tutto, sua moglie scelse di sostenerlo sin da subito, comprendendo che il suo ruolo di magistrato fosse una missione, più che una professione. Dopo venti mesi di processo di primo grado, su 475 imputati vennero sentenziati 19 ergastoli e pene detentive pari in totale a 2665 anni di reclusione.

Uomini, prima che eroi
Dopo quanto fatto col Maxiprocesso e non solo, viene spontaneo accomunare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a degli eroi. Nel libro Pietro Grasso sceglie di raccontare invece il loro lato umano, oltre la figura di giudici.
“Giovanni e Paolo non avevano poteri sovrannaturali – ci tiene a sottolineare l’onorevole Grasso – ma erano persone come tutti noi, che vivevano momenti di vita professionale e di relax con grande umanità. Insieme si completavano: Paolo aveva un forte spirito goliardico, sempre pronto allo scherzo. Amava il contatto con le persone, tant’è che mi confessò gli sarebbe piaciuto fare il portiere di condominio per poter parlare con gli inquilini. Spesso veniva in studio vestito informale, indossando una polo Lacoste, e mentre studiava i casi poggiava le gambe sul tavolo. Alcuni volte capitò addirittura che sfuggisse alla scorta”.
Di Falcone invece Pietro Grasso ci offre un’immagine diametralmente opposta, almeno in apparenza: “Giovanni era più serioso e distaccato, mostrava diffidenza verso quelli che entravano in contatto con lui. Diceva: non sai mai chi ti sta dietro e chi ti sta davanti. Ma quando questo scudo cadeva, riusciva a essere affabile e regalare battute dallo humor inglese”.

La sindrome del sopravvissuto
Il dialogo tra Pietro Grasso e Paolo Valsecchi, attento interlocutore durante tutte le risposte dell’onorevole, giunge infine a quel fatidico 23 maggio 1992, giorno in cui Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorta, perse la vita in quella che viene chiamata la strage di Capaci, attentato terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra.
“Dovevo esserci anche io in macchina con lui – sospira l’onorevole Grasso – non c’è giorno in cui non ci pensi. Spesso mi sento in colpa di essere sopravvissuto a Paolo e Giovanni: ero in trincea insieme a loro, combattevamo insieme, ma loro sono morti e io sono ancora qui. Con la loro scomparsa ho perso degli amici, dei maestri, delle guide. A volte mi sono chiesto: se non avessimo fatto il meglio durante il Maxiprocesso, sarebbero ancora vivi? Ma poi ho razionalizzato il tutto e mi sono reso conto che avremmo continuato fino al raggiungimento della giustizia”.
Prosegue commosso il racconto: “La sera prima dell’attentato riuscii a trovare un volo da Roma per Palermo. Sedile 1L, me lo ricordo ancora, probabilmente lasciato vuoto da un parlamentare all’ultimo minuto. Non appena seppi la notizia, corsi in ospedale con la speranza che Giovanni ce la facesse. Aveva sempre resistito a tutto. Poi ho visto lo sguardo di Paolo e capii che non c’era più nulla da fare, e che la ragione non poteva prevalere su 500 kg di esplosivo posizionati sotto un’autostrada“.
All’improvviso, Grasso estrae dalla tasca un accendino, attizza la fiamma e visibilmente emozionato spiega: “Questo accendino d’argento me l’ha dato Giovanni durante uno dei nostri viaggi Roma-Palermo. Me lo porse dove averlo cercato nella borsa e mi disse: Pietro devi tenerlo tu, ho deciso di smettere di fumare. Però non è un regalo eh, se decido di ricominciare devi ridarmelo. Non ho più avuto l’occasione di restituirglielo, resta uno dei ricordi che ho di lui, della persona eccezionale che era, ricordi che voglio trasmettere a tutti i ragazzi per far sì che non venga dimenticato”.

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL