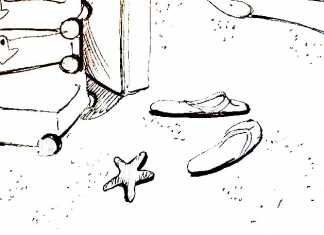LECCO – “Su cento malati effettivi, almeno 25 non sanno di avere contratto l’infezione”. L’AIDS continua a fare paura anche nel lecchese e lo si capisce bene dalle parole del dott. Paolo Bonfanti, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Manzoni.
Sono circa 630 i pazienti curati nel nosocomio lecchese, la maggior parte dei quali hanno contratto il virus (HIV) ma non sono allo stadio avanzato della malattia (AIDS) e restano sottoposti a terapie per evitare che si aggravino.
“Rispetto al passato sono stati fatti enormi passi avanti e oggi l’AIDS è trattata in modo analogo ad una patologia cronica, riuscendo a controllarla e ad assicurare al paziente una vita pressoché normale – ci spiega il primario – L’aspettativa di vita, se il paziente si accorge in tempo di avere contratto il virus, grazie alle nuove terapie è solo leggermente più bassa rispetto a quella di un paziente non infetto. Per intenderci, se un 35enne ad uno stadio non avanzato della malattia, che si sottopone regolarmente alle cure farmacologiche, può arrivare a vivere anche oltre i 70 anni di età. Il prezzo da pagare c’è perché le terapie portano alcuni effetti collaterali ma questo è qualcosa di comune a tutte le malattie cronache”.
Il problema è rendersi conto di aver contratto l’infezione prima che sia troppo tardi, poiché nella maggioranza dei casi resta a lungo silente, senza manifestare sintomi:
“Appena contratta l’infezione, pochi giorni o settimane dopo, solo alcuni pazienti manifestano febbre e disturbi simili a quelli influenzali, con linfonodi ingrossati o sfoghi cutanei. L’altra grossa fetta di pazienti, ancora oggi rilevante, arriva quando la malattia è già avanzata e questo stadio può presentarsi anche cinque o sette anni dopo – sottolinea il dott. Bonfanti – A quel punto possono mostrarsi sintomi meno gravi come perdita di peso, stanchezza intensa, diarrea ricorrente, fino ad arrivare a pazienti che hanno malattie opportunistiche come forme di polmonite o alcuni tipi di tumore che colpiscono solo i soggetti immunodepressi. In quei casi si sottoscrive il test e si scopre l’infezione”.
A proposito del test, è possibile effettuarlo gratuitamente e in anonimato sia in ASL che all’ospedale.
 “Ad effettuarlo sono soprattutto soggetti giovani o più in genere gli appartenenti alla fascia sessualmente attiva, dagli adolescenti fino alle persone di 55 anni che si mettono in condizione di rischio. E’ una malattia che si trasmette esclusivamente per via sessuale, la condizione di promiscuità e rapporti non protetti crea il rischio. La trasmissione del virus attraverso il sangue era qualcosa che accadeva in passato, quando non si effettuavano i controlli specifici su questa malattia nelle trasfusioni. Ora come ora dovrebbe avvenire un contatto da ferita a ferita, il che è qualcosa di molto teorico”.
“Ad effettuarlo sono soprattutto soggetti giovani o più in genere gli appartenenti alla fascia sessualmente attiva, dagli adolescenti fino alle persone di 55 anni che si mettono in condizione di rischio. E’ una malattia che si trasmette esclusivamente per via sessuale, la condizione di promiscuità e rapporti non protetti crea il rischio. La trasmissione del virus attraverso il sangue era qualcosa che accadeva in passato, quando non si effettuavano i controlli specifici su questa malattia nelle trasfusioni. Ora come ora dovrebbe avvenire un contatto da ferita a ferita, il che è qualcosa di molto teorico”.
Il primario ha voluto ricordare che l’uso del preservativo non azzera dalla trasmissione del virus perché c’è il pericolo che possa rompersi. “Una persona che contrae l’HIV deve comunque, in una relazione affettiva, dichiararlo – ha spiegato il dottore – E’ un rischio piccolo quello della rottura del preservativo ma è giusto che il partner ne sia a conoscenza. Non si tratta di precludersi alla vita affettiva, ma servono comportamenti responsabili verso l’altro”.
Diversi sono i casi di infezione seguiti dal medico dove una relazione extraconiugale ha causato l’infezione del partner: “Il soggetto più fragile è la donna, ignara di essere stata esposta dal proprio compagno al rischio di infezione, che si sottopone al test e scopre di avere la malattia. E’ un fatto che evidentemente sconvolge la coppia e in 20 anni di esperienza ho visto come questo abbia provocato la rottura di rapporti oppure la decisione di affrontare insieme il problema”.
Ci sono poi i pazienti di origine straniera e in Lombardia si stima siano in una percentuale del 25% rispetto al totale dei malati, la maggior parte proveniente dall’Africa, una delle terre ancora oggi tra le più colpite dal virus. Il contagio può avvenire anche da madre a figlio ma fortunatamente a Lecco non si sono mai verificati casi simili:
“Questo perché da diversi anni le donne durante la gravidanza vengono sottoposte al test dell’HIV e se una paziente risulta sieropositiva vengono usate delle terapie per abbattere la presenza del virus nella mamma ed impedirne la trasmissione, che generalmente avviene durante il parto, nel contato tra il sangue della madre e il figlio. Se, nonostante la terapia, permane alto il livello di virus nel sangue, allora si opta per il parto cesareo”.
Alle procedure mediche si somma una rete di soggetti e associazioni, dentro e fuori dall’ospedale, per dare supporto al malato e recentemente l’Azienda Ospedaliera ha inserito anche la figura del mediatore culturale per abbattere quelle difficoltà, anche linguistiche, con i pazienti non italiani. Il problema, oggi come ieri, è quello di far emergere il “sommerso”, ovvero quelle persone che non sanno di aver contratto il virus.
“Abbiamo fatto campagne anche con i medici di medicina generale per sensibilizzare la cittadinanza – conclude il primario – perché chi si mette a rischio deve effettuare il test ed evitare che l’infezione possa propagarsi ancora”.

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL