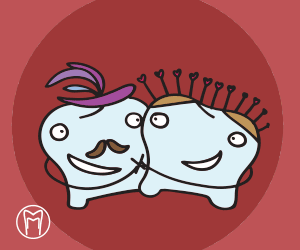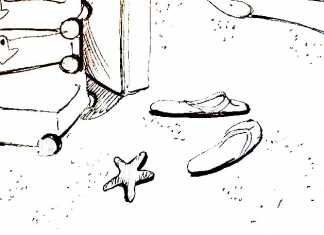LECCO – “Tutto è iniziato a Como il 6 marzo 1944. C’erano scioperi dal 1943 ma sotto il fascismo era impossibile scioperare. A una certa ora i lavoratori si fermarono. Arrivò la polizia, che trovò dei manifestini. Io lavoravo in una fabbrica che produceva paracaduti anche per i tedeschi. Prima che i cancelli venissero aperti, ho fatto il possibile per difendere le persone che venivano portate via per essere poi trasferite in Germania. Non ero né sindacalista né attivista politica. Perché l’ho fatto? Semplicemente per me è stato spontaneo oppormi a una simile ingiustizia”.
E’ cominciata così la testimonianza di Ines Figini, classe 1922, sopravvissuta ad Auschwitz, agli studenti dei licei scientifico e artistico e ai ragazzi di terza media del Collegio Volta di Lecco.
“Quel giorno – ha spiegato – il questore mi disse: “Visto che sei così decisa, se riprendete a lavorare per oggi non portiamo via nessuno”. Ma di notte arrivarono a casa i fascisti. Io non aveva ancora 22 anni”.
Ines Figini fu interrogata dal commissario e, il mattino successivo, portata alla palestra Mariani. Poi alla stazione e, da lì, a Bergamo. In caserma una ragazza si sentì male. Arrivò un medico italiano, il quale cercò di convincere i tedeschi che la giovane non poteva affrontare il viaggio e per sua fortuna la ragazza fu rimandata a casa.
“Il giorno della partenza – ha ricordato sempre Ines Figini – arrivarono i vagoni piombati. Le ragazze viaggiavano con il comando tedesco. Io speravo di restare in Germania a lavorare per 2 o 3 anni, non sapeva cosa mi aspettava. Il viaggio fu tremendo. Era marzo e faceva freddo. Anche non conoscere la meta era un logorìo temendo”.
C’è stato naturalmente spazio anche per il racconto della terribile esperienza nel campo di concentramento, nella testimonianza di Ines Figini.
“Il campo era grandissimo. Arrivate a Birkenau ci fecero scendere. Sul posto c’era la squadra del famigerato dottor Mengele, mentre un altro gruppo sceglieva chi poteva lavorare. Gli altri finivano nelle camere a gas. Avevamo l’impressione di trovarci all’inferno: confusione terribile, dolore, pianti”.
“In un capannone – ha aggiunto – fummo fatte sfilare davanti a un ufficiale che tatuava i deportati. Le docce, poi un’ausiliaria ci portò nel dormitorio. Al mattino sveglia e bagno, un’esperienza terribile. Poi l’appello. Nessuno poteva muoversi. A volte il freddo era così intenso che non si riusciva a parlare. Quindi ci si incamminava per andare a lavorare. Ci portavano vicino a una palude, dove dovevamo scavare canali per prosciugarla, un lavoro estremamente pesante. Per pranzo veniva distribuita una zuppa nella gavetta che ogni detenuta aveva con sé e io mi sforzavo di mangiare giusto per sopravvivere. Pensavo al minestrone della mamma, per farmi venire l’acquolina…”.
Si pensava a casa, si pregava. E lì, in quel contesto estremo, più che pregare nel senso classico del termine si parlava con Dio.
Da libera, Ines ogni anno torna a camminare su quello stesso campo. Riesce a farlo con uno spirito libero perché, nonostante tutto, è riuscita a perdonare. “Odio e vendetta ottenebrano il cervello”, ha ripetuto agli studenti del “Volta”. Per poi aggiungere: “Bisogna pensare e ragionare, con la testa e con il cuore”.
 Si arriva così al settembre del ‘44: giunge voce che i russi si avvicinano. In novembre Ines viene mandata a Ravensbrück e lavora per la Siemens. Poi in un altro campo, dove non si lavorava più. Veniva però distribuita soltanto una fetta di pane al giorno, finché arrivò l’ordine di partire per la “marcia della morte”. Una settimana o 10 giorni di cammino.
Si arriva così al settembre del ‘44: giunge voce che i russi si avvicinano. In novembre Ines viene mandata a Ravensbrück e lavora per la Siemens. Poi in un altro campo, dove non si lavorava più. Veniva però distribuita soltanto una fetta di pane al giorno, finché arrivò l’ordine di partire per la “marcia della morte”. Una settimana o 10 giorni di cammino.
“Nelle fattorie – ha spiegato sempre Ines Figini – i soldati chiedevano qualcosa da mangiare, soprattutto patate. Arrivammo in un paesino dove sostammo qualche giorno dentro una stalla. Io ero con due slave, una signora di Trieste e una di Genova. Una notte scoprii che i soldati tedeschi erano tutti scappati e al mattino vidi un ragazzo russo, un soldato dell’Armata rossa. Era il 5 maggio 1945. Ci disse che Mussolini era morto e che la guerra era finita”.
Al comando di zona dissero alle donne di raggiungere una postazione militare distante 100 chilometri. Come fare? Ines vide un carro e fermò i soldati francesi che, essendo ormai giunti a destinazione, le diedero il loro mezzo di trasporto. Trovarono due soldati italiani… Dopo quasi 2 anni di prigionia, qualcosa di incredibile!
Poi un accorato appello agli studenti che la ascoltavano. “Cari ragazzi – ha detto loro – non dimenticate mai che la libertà è gioia, ma anche disciplina e responsabilità”.
Durante il viaggio di ritorno scoppiò un’epidemia di tifo. Oltre il decorso della malattia, bisognava fare 40 giorni di isolamento e Ines si ammalò. Un’équipe di medici russi la mise su un camion e la portò in un ospedale. Era disperata. Ma quando vide la cameretta, pulita e con tanto di lenzuola bianche, non le sembrò vero.
Ines Figini venne curata soltanto con acqua bollita e la malattia si protrasse per quasi 5 mesi.
Si arriva ai primi di ottobre del ‘45: passò delegazione americana che ordinò la dismissione del campo. Ines pregava: “Se devo morire, Signore, fammi morire almeno in Italia”. Il medico le disse: “Se stai almeno 8 giorni senza la febbre, ti faccio partire”. E qui accadde un miracolo: la febbre sparì e così poté partire.
Arrivata in Austria, fu lavata e disinfettata dagli inglesi. Arrivò a Pescantina, nel Veronese. Qui ricevette un pastina deliziosa e due rosette di pane. Poi un’altra autocolonna inglese per la stazione, infine in treno fino a Como. Così tornò a casa, anche se fu costretta a rimanere a letto per 5 mesi.
Ines non ha mai avuto un incubo, forse perché ha perdonato. Ogni anno torna ad Auschwitz e sente una fortissima pace dentro di sé. Anche nel campo lei si sentiva sicura di tornare a casa. Spesso parlava con se stessa e così si faceva forza.
“Sì, l’ottimismo non mi è mai mancato – ha concluso – e mi dicevo che la guerra prima o poi sarebbe finita. Anche la preghiera mi ha aiutato molto, perché io non ho mai perso la fede”.

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL