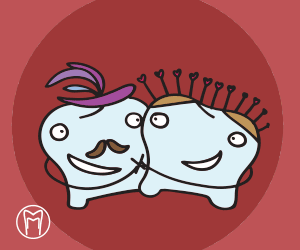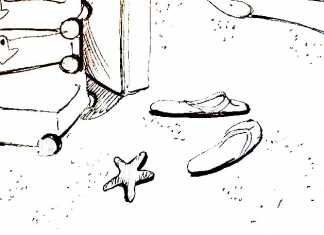Ogni lavoro ha una sua fatica. Essa scaturisce dall’incontro con la resistenza che la realtà, umana o materiale, oppone allo sforzo che il desiderio mette in campo per trasformarla, secondo le sue aspettative. Ogni lavoro possiede , dunque, una fatica che gli è propria, che gli appartiene come un tratto che lo identifica. Capita , a volte, che venga socialmente riconosciuta, come tale, altre volte meno. Dipende, il più delle volte, da come viene considerata quella realtà nei confronti della quale il lavoro dovrebbe agire.
Ogni lavoro ha una sua fatica. Essa scaturisce dall’incontro con la resistenza che la realtà, umana o materiale, oppone allo sforzo che il desiderio mette in campo per trasformarla, secondo le sue aspettative. Ogni lavoro possiede , dunque, una fatica che gli è propria, che gli appartiene come un tratto che lo identifica. Capita , a volte, che venga socialmente riconosciuta, come tale, altre volte meno. Dipende, il più delle volte, da come viene considerata quella realtà nei confronti della quale il lavoro dovrebbe agire.
Spesso si suppone che questa realtà sia dura come una pietra o , invece, che sia morbida e malleabile come burro. Una sostanza plasmabile, modellabile a piacimento, con uno sforzo minimo. E’ quel che, all’occasione , si traduce nel discorso comune con frasi di circostanza del tipo “basta metterci un po’ d’impegno”, “è solo un capriccio”…
Sono trascorsi decenni nei quali la droga ha fatto avvertire tragicamente la sua presenza nel cuore stesso della nostra società, eppure nonostante tutto questo si continua a considerare il fenomeno della tossicodipendenza come un errore di percorso, un inciampo… Si pensa al tossicomane come a un vizioso che è caduto incidentalmente a terra. Tutti, non escluso lui stesso, pensano che ora sia sufficiente rialzarsi, scrollarsi di dosso la polvere dai vestiti con gesti secchi e un movimento deciso per riprendere subito con passo spedito il suo cammino verso quegli obiettivi che , quasi spontaneamente, il normale buon senso gli addita : la famiglia e il lavoro.
Insomma, che cosa ci vuole? La domanda sollecita una risposta pronta, sovente automatica che , non di rado, compare con inaudita frequenza nella retorica che abbonda nella chiacchera comune: “ se non smette, è perché non vuole…” . Formula che esclude qualsiasi riferimento, anche minimo, all’idea di una fatica e dunque di un lavoro. Purtroppo, e lo dico con intima sofferenza, non è così. Anzi, ad esser sinceri, non è mai stato così, nemmeno quando si profetizzava il ricorso alle droghe come via privilegiata per accedere a una nuova consapevolezza di sé o altre stupidaggini del genere. Più si conosce chi fa uso e abuso di queste sostanze, ivi compreso il ricorso all’alcool nel qual caso non fossero reperibili, più ci accosta a storie di individui segnate da ferite, talmente profonde e precoci da non riuscire a essere mentalmente riprese nella loro drammaticità da parte dei soggetti che le hanno subite.
Per questa ragione, la droga finisce per rappresentare il palco oscuro sul quale un essere umano mette in scena, in totale e inconsolabile solitudine, lo spettacolo della sua morte. Offerto generosamente agli altri affinché qualcuno, uscendo dal cono d’ombra dell’indifferenza o del moralismo, si faccia avanti tendendogli una mano. E’ un gesto non facile e , per altro, non gratuito. Un gesto che, quando non vuole essere semplicemente tale , ambendo di fatto a esplicitare un’effettiva disponibilità, umana e professionale, implica una dedizione che assorbe per intero la persona che lo compie. Un gesto, infine, di cui non occorre mai dimenticare l’ambito paradossale nel quale si dispiega: sostenere un soggetto nella sua lotta contro quella morte che non gli è precipitata addosso come una sventura improvvisa, come il manifestarsi impietoso di una causalità imprevedibile, ma , al contrario, come l’esito di una condotta che lui stesso ripetutamente, ostinatamente cerca. Quasi aderisse a un richiamo irresistibile che lo strappa lontano da sé.
Non è , forse, di questo che la droga ci parla? Di questo dolore ad esistere che il tossicomane sconta nella sua vita , trascinandosi a stento tra esperienze talvolta umilianti , spesso fallimentari, confortato solo da una velleità consolatorio che poi, a ben vedere, è solo il riflesso di quella superficialità che i benpensanti gli ributtano sdegnosamente in faccia, quella , per l’appunto, di “voler” farsi, di “voler” eccedere, cioè di “voler”… annullarsi.
E’ di fronte a questa realtà, tanto cruda quanto mistificata nella sua essenza, che acquista un senso specifico la prospettiva del lavoro e della fatica cui si accennava all’inizio. Se la droga non è un vizio, ma la spia buia di una passione per il proprio essere che il tossicomane non è mai riuscito a costruire, allora si può intuire la misura della fatica che sollecita per venirne a capo, per permettere a un soggetto di intraprendere una vita diversa. Ciò inevitabilmente non va da sé. Comporta un lavoro che si sviluppa negli anni, lentamente, fatto di cadute, di cedimenti, di incomprensioni, di risalite e… Così è , d’altronde, e così non può essere altrimenti.
Lavoro doppio, ovviamente. Lavoro del tossicomane nel far i conti con quel che mal padroneggia ad ogni livello, lavoro dell’operatore nel prestarsi a divenire un suo fidato interlocutore, anche quando è chiamato a schierarsi con quella voce afona che nel tossicomane esige la vita in opposizione ai quei comportamenti ridondanti che paiono anelare solo alla propria repentina dissoluzione. Abita qui il fuoco che deve alimentare le motivazioni che sorreggono l’azione di una comunità che interviene sulle problematiche della tossicomania. Il suo lavoro, infatti, partecipa della nobiltà che a giusto titolo appartiene a questo termine. Ma, forse, veicola anche un messaggio, in più. L’invito a cogliere la verità di un disagio che tocca non poche persone e dietro al quale s’intravedono storie e sentimenti che unicamente il lavoro sa portare alla luce. Un mondo inascoltato che domanda parola e attenzione e non quell’atteggiamento frettoloso con cui si è soliti liquidarlo, in nome di chissà quale altera superiorità.
ARTICOLI PRECEDENTI
15 ottobre – Nasce CALeidoscopio la nuova rubrica dedicata al sociale

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL