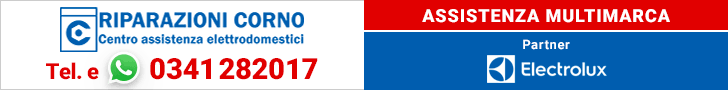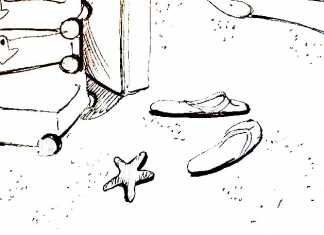Che cosa significa educare? E’ una domanda a cui non è facile rispondere, da sempre. Oggi, probabilmente, ancor di più, il termine educare appare come estremamente enigmatico. Ciascuno vi associa i significati che maggiormente gli convengono, assegnando così al verbo una valenza quasi immaginaria, tanto si carica di echi suggestivi, ma il più delle volte labili, inconsistenti.
Che cosa significa educare? E’ una domanda a cui non è facile rispondere, da sempre. Oggi, probabilmente, ancor di più, il termine educare appare come estremamente enigmatico. Ciascuno vi associa i significati che maggiormente gli convengono, assegnando così al verbo una valenza quasi immaginaria, tanto si carica di echi suggestivi, ma il più delle volte labili, inconsistenti.
Va da sé che, tuttavia, per chi opera all’interno di una comunità che si occupa del recupero di persone tossicodipendenti, tale questione non può venir in nessun modo elusa o dispersa nei rivoli di fantasiose costruzioni. L’educare costituisce infatti il cuore stesso della prassi di intervento in comunità, per quanto risulti alquanto palese il suo carattere fortemente paradossale. Un conto è educare un bambino, insegnandogli le cosiddette buone maniere; un altro è misurarsi con adulti che, probabilmente, non ignorano quali siano le buone maniere, ma che hanno soggiaciuto a una vita autodistruttiva, sregolata.
Il tossicodipendente non è, quindi, una persona maleducata o che non è stata educata, in famiglia. La sua storia individuale porta le tracce di un’esperienza in tal senso. E allora, si dirà, perché ricorrere a quel verbo? Perché gli operatori in comunità sono qualificati professionalmente come educatori ? Che genere di educazione è qui in gioco?
Proverei a tracciare questa distinzione. Esiste un’educazione che ha che fare con un “più” e un’altra, se così posso esprimermi, con un “meno”. Grosso modo, il primo tipo di educazione è quello più propriamente tradizionale. La confusione che nei tempi attuali grava sui contenuti che questa prassi dovrebbe avere non ne sminuisce la portata di fondo, quanto meno in forma generale. Educare qui vuol dire o , forse, dovrebbe voler dire introdurre un limite a un eccesso di condotta “esuberante” da parte di un minore, ponendo un freno a richieste esagerate ed eccessive, a comportamenti incivili che non tengono conto della presenza degli altri o del rispetto che gli è dovuto. Educare implica dunque il favorire l’accesso dell’educando alla dimensione del dovere, complemento necessario a quella del diritto.
C’è , però, un’altra educazione o , se vogliamo, un altro tipo di educazione, quale quella che impegna gli operatori di una struttura che lavora con individui segnati da patologie spesso devastanti. Si tratta, in questo caso, di un’educazione che ha a che fare con un “meno” dal lato del soggetto. Un “meno” che si traduce in un’impossibilità a vivere, ad appropriarsi della propria esistenza. L’esuberanza di poc’anzi cede qui il passo a una deriva spesso melanconica, depressiva, come se la persona si chiamasse fuori da sé stessa, dalla sua storia, dal suo corpo. Le sostanze offrono qui una via d’uscita privilegiata, a portata di mano, puri strumenti di degenerazione e di morte. Educare implica allora sostenere un progetto che permetta a un’iniziativa, a un’ambizione di trovare spazio, regalando alla vita quella volontà ad esserci che sembra totalmente mancare. Il compito dell’educatore è quello di educare, per l’appunto, alla vita o meglio ancora a quel che è importante sussista affinché quest’ultima recuperi una ragione per andare avanti. E’ un’operazione complessa che si sviluppa su due piani ,profondamente intrecciati tra di loro, l’uno non sta in piedi senza l’altro. Il primo è quello teso a motivare, aiutare, sorreggere il tossicodipendente nella faticosa conquista di un desiderio suo, di una strada che gli liberi un accesso personale al mondo che sta fuori di lui. Il secondo è quello volto a introdurre una barriera alla china di distruzione che l’uso delle droghe inevitabilmente promuove. Il primo piano non può legittimarsi senza il secondo. Ridurre questo tipo particolare di educazione unicamente al primo piano comporta l’arroccarsi in una posizione prettamente ideale, per quanto sorretta dal conforto del ritorno narcisistico che ne può derivare: “io sono il bravo educatore, io sono quello che mostra ed elargisce le buone cose della vita che il tossicomane dovrebbe assimilare”. Al contrario, considerare la pratica educativa come attinente solo al secondo piano ha come esisto quella di farne un esercizio sadico, fonte di una relazione pervertizzante. Occorre, ripeto, che il primo piano si sposi con il secondo. E che soprattutto il tossicomane sperimenti l’incontro con la dialettica tra l’uno e l’altro all’interno di una relazione autentica e, non dimentichiamolo, quotidiana. Educare è un gran lavoro, anzi è un lavoraccio, pesante e pensante. Kant sosteneva che era una professione impossibile, Freud era d’accordo. Ciò non toglie che anche in quest’impossibilità non si scoprano opportunità inattese, gradevoli sorprese. E anche qualche piccola o parziale risposta alla domanda da cui sono partito.
ARTICOLI PRECEDENTI
10 dicembre – Il vento ci porterà…
3 dicembre – Essere genitori dentro ad un conflitto nella coppia
26 Nvembre – Una professione in cammino
19 novembre – La famiglia errante
12 novembre – … è solo un farmaco…
5 novembre – A cavallo della vita. Per un desiderio del disabile
29 ottobre – L’iperattività si eredita?
22 ottobre – La droga non è un vizio. Una riflessione sul lavoro sulla tossicomania
15 ottobre – Nasce CALeidoscopio, la nuova rubrica dedicata al sociale

 RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL